Contenuto della pagina
IL RICONOSCIMENTO DELLA COPPIA FA BENE ALLA SALUTE E... ALLA SOCIETÀ!
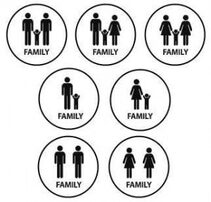
A cura di Cristiano Scandurra
A breve, precisamente il 28 Gennaio
2016, i parlamentari italiani si esprimeranno con il proprio voto in merito al
disegno di legge Cirinnà (a questo link è possibile scaricare il testo
integrale http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39314.htm).
Voteranno, cioè, l'approvazione o meno delle unioni civili per le coppie
cosiddette same-sex, ovvero coppie
costituite da persone gay e lesbiche. Non è stato facile il cammino di questo
disegno di legge e il suo esito non è a tutt'oggi per nulla noto. Più volte,
infatti, il Parlamento ha rimandato la decisione legata alla sua approvazione.
Eppure l'Italia è l'unico Stato tra i 6 fondatori dell'Unione Europea a non
aver ancora riconosciuto né le unioni civili né il matrimonio same-sex. Ci sono dunque forti
resistenze a compiere questo passaggio. Le forze politiche si oppongono
vicendevolmente ed il conflitto finisce sempre per mettere un bavaglio al
progresso. Speriamo che questa sia la volta buona! Non solo perché così
l'Italia starebbe a passo con il resto dell'Unione Europea, da sempre attenta
ad garantire diritti civili. Uno tra i motivi è certamente questo. Ma non è
solo una questione politica! Piuttosto, sembrerebbe trattarsi di un'azione
finalizzata al miglioramento della salute sia delle persone lesbiche e gay che
della società in generale. Strano legame quello tra l'approvazione di una legge
e la salute mentale e sociale, se così si può dire. Eppure, alcuni ricercatori
americani - nello specifico Mark Hatzenbuehler, Conall O'Cleirigh, Chris
Grasso, Kenneth Mayer, Steven Safren e Judith Bradford - in uno studio del
2010, hanno dimostrato che le persone lesbiche e gay che vivono in quegli Stati
americani in cui è assente una legge sul riconoscimento delle unioni same-sex presentano livelli di ansia,
depressione ed uso di sostanze molto più elevati di coloro che, al contrario,
vivono in Stati in cui questo riconoscimento è presente. Gli autori ne deducono
che le politiche di riconoscimento delle coppie same-sex hanno un effetto altamente protettivo nei confronti della
salute mentale delle persone lesbiche e gay. Ma la storia non finisce qui. Altri
autori, tra cui compare sempre in prima linea Mark Hatzenbuehler - seguito da Katie
McLaughlin, Katherine Keyes e Deborah Hasin - in uno studio pubblicato nel
2012, si sono spinti ancora oltre, supponendo che, laddove queste politiche
migliorino la qualità della vita ed accrescano i livelli di salute mentale,
sarebbe ragionevole pensare che esse possano avere anche importanti
implicazioni sociali, quali quelle dell'utilizzo dei servizi di salute mentale
e le spese sanitarie. E infatti, in questo studio sperimentale condotto su un
campione di 1211 uomini gay che avevano avuto accesso ad una clinica del
Massachusetts, è emerso proprio che nei 12 mesi successivi alla legalizzazione
del matrimonio same-sex, c'è stata
una significativa decrescita delle visite mediche generali, psichiatriche e
psicologiche, così come una riduzione dei costi sanitari, rispetto ai 12 mesi
che precedevano la legalizzazione. Ma un dato ancora più interessante è che il
legame tra l'approvazione giuridica del matrimonio same-sex, il calo delle visite mediche e psicologiche ed il
risparmio sanitario, non risulta essere associato con lo status sociale della
partnership. Ciò significa che gli effetti protettivi sulla salute mentale e
sui sistemi sanitari del matrimonio same-sex
sono validi ed efficaci sia per le coppie che per i single. Viene allora da
chiedersi perché, fino ad ora, il nostro Stato - come tanti altri nel mondo -
non abbia ancora legiferato a riguardo. Forse perché non tutti conoscono questi
studi? Opinione senza dubbio banale...La risposta, credo, può essere trovata
nell'azione diffusa e pervasiva dell'ideologia omofobica e maschilista,
talmente dilatata che finisce per impregnare le istituzioni sociali. Anche in
assenza del pregiudizio del singolo individuo, cioè, è possibile che lo stigma
rivolto alle persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) si incisti
nelle organizzazioni e sia agito dalla stessa organizzazione in qualità di
entità astratta. Stiamo parlando del cosiddetto stigma strutturale o istituzionale (Hatzenbuehler & Link, 2014).)
Ad esempio, se un'organizzazione sanitaria pubblica del nostro Paese non
prevede l'assistenza sanitaria per coppie che non siano sposate o
etereosessuali, i partner dello stesso sesso (per di più non sposati, dato che
in Italia questo non è ancora possibile) ne rimarrebbero automaticamente fuori,
anche se per il singolo medico non rappresentasse un problema. Il risultato è
che la coppia costituita da persone dello stesso sesso sarebbe implicitamente
assegnata ad uno status inferiore rispetto a quello ricoperto dalla coppia
costituita da persone di sesso diverso. Bene! Il problema è che anche il
Governo è un'istituzione, un'istituzione che fino ad oggi sembra aver agito in
nome dello stigma istituzionale rivolto ad una fetta di cittadini che, pure,
esso rappresenta. Ma, se il riconoscimento della coppia fa bene sia alla salute
del singolo che a quella della società, se tale riconoscimento addirittura migliora le casse della sanità pubblica, non
sarebbe forse il caso di rivedere le politiche interne superando lo stigma
istituzionale?
Bibliografia
utilizzata:
- Hatzenbuehler, M. L., & Link, B. G. (2014). Structural stigma and the
health of lesbian, gay, and bisexual populations. Current Directions in
Psychological Science,
23(2), 127-132.
- Hatzenbuehler, M.
L., O'Cleirigh, C., Grasso, C., Mayer, K.,, Safren, S., & Bradford, J.
(2012). Effect of same-sex marriage laws on health care use and expenditures in
sexual minority men: A quasi-natural experiment. American Journal of Public Health, 102(2), 285-291.
- Hatzenbuehler, M.
L., McLaughlin, K. A., Keyes, K. M., & Hasin, D. S. (2010). The impact of
institutional discrimination on psychopathology in LGB populations: a
prospective study. American Journal of
Public Health, 100(3),
452-459.


