Contenuto della pagina
Scomparsa di Lucy Salani, testimone di libertà e resistenza
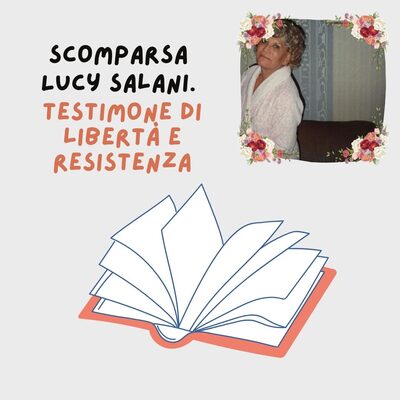
A cura di Claudia
Cantice e Emilia De Simone.
La comunità
LGBTQIA+ piange la scomparsa di Lucy Salani, a quasi 99 anni. Lucy era nota per
essere l’unica persona trans italiana sopravvissuta ai campi di concentramento
nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Salani, dopo la guerra, divenne
anche un’attivista antifascista e per i diritti delle persone LGBT+ piuttosto
nota, e la sua storia è stata raccontata in libri e documentari.
Lucy Salani nacque
a Fossano, in Piemonte, il 12 agosto 1924, da una famiglia antifascista.
Trascorse parte della sua giovinezza a Bologna, finché allo scoppio della
guerra, prima della sua transizione, fu chiamata in servizio dall’esercito
italiano. Da allora, disertò due volte: la prima dopo l’armistizio italiano
dell’8 settembre del 1943 e la seconda, quando fu costretta a unirsi alle
truppe fasciste, in seguito all’occupazione da parte dell’esercito nazista di
molti territori italiani. Venne scoperta e mandata nel campo di lavoro forzato
di Bernau, in Germania. Riuscì ancora a scappare, ma nuovamente scoperta fu
internata nel campo di concentramento di Dachau.
Dal momento che aveva
disertato, fu contrassegnata con il triangolo rosso, il segno di riconoscimento
dei prigionieri dei campi di concentramento: per i prigionieri ebrei, erano due
triangoli gialli disposti a formare una stella, mentre quello rosso distingueva
gli ebrei dai prigionieri politici, tra cui i disertori.
A Dachau
sopravvisse per sei lunghi mesi. Dai suoi racconti si apprende che era
costretta a portare avanti compiti disumani, come quello di contare i cadaveri
e assegnare loro, non un nome, bensì un numero. Resistette fino al giorno della
liberazione da parte degli Alleati, quando poco prima di abbandonare il campo,
le guardie naziste -ormai spalle al muro- cominciarono a sparare sui
prigionieri dalle torrette di Dachau, colpendo Salani a una gamba, la quale fu
ritrovata solo successivamente, viva, tra i cadaveri.
Dopo la guerra,
Lucy tornò in Italia, visse tra Torino e Roma, spostandosi per un periodo anche
a Parigi. Si sottopose all’operazione di riattribuzione del sesso a Londra,
negli anni Ottanta, senza tuttavia rettificare all’anagrafe il suo nome di
nascita, Luciano. Tornò a Bologna, città dove aveva trascorso la sua
giovinezza, e dove è rimasta fino alla morte.
Salani si è
distinta come attivista antifascista e per i diritti delle persone LGBT+ e la
storia della sua vita ha acceso l’interesse di molti. Infatti, è stata
raccontata nel libro del 2009 “Il mio
nome è Lucy. L’Italia del XX secolo nei ricordi di una transessuale” di
Gabriella Romano, e più di recente nel documentario realizzato da Matteo
Botrugno e Daniele Coluccini “C’è un
soffio di vita soltanto” (2021). È stata anche intervistata nel
documentario “Felice chi è diverso”
(2014), diretto da Gianni Amelio.
Per saperne di più:
I registi, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, hanno
condiviso con lei gli ultimi anni di vita, lavorando al suo fianco per la
realizzazione del documentario che racconta la
sua storia. “C’è un soffio di vita soltanto” ripercorre la vita di Lucy
tra le atrocità della deportazione e le difficoltà vissute derivanti dal suo
essere donna trans in un’Italia ricca di pregiudizi.
I registi, alla
notizia della sua scomparsa, hanno
espresso la loro emozione con queste parole: “Abbiamo avuto il privilegio e
la fortuna di conoscere Lucy qualche anno fa e da quel momento è iniziato un
legame indissolubile, un legame che va al di là degli aspetti artistici e
professionali. Lucy è diventata un punto di riferimento umano per noi e per le
tante persone che hanno conosciuto la sua storia e che l’hanno amata per la sua
resistenza, il suo orgoglio, la sua forza straordinaria. Lucy se ne è andata,
ma il suo ricordo e la sua storia rimarranno scolpiti non solo nella memoria di
chi, come noi, le ha voluto bene, ma anche nella memoria collettiva del nostro
paese”.
Lo scorso luglio
il Comune di Bologna, città cui era legata, le ha conferito la Turrita di
bronzo, riconoscimento per il suo essere stata testimone di libertà e
resistenza. Come scritto nelle motivazioni di tale scelta: “La città intende
darle tale onorificenza come un proposito e un auspicio ad essere sempre come
la sua cittadina Lucy: città libera, resistente ai soprusi e alle ingiustizie,
e custode di memorie, accogliente e plurale”.
In questo mese in
cui ricade la Giornata Internazionale della Donna, abbiamo deciso di incentrare
la nostra newsletter su contributi aventi come filo conduttore l’obiettivo di
mettere in risalto storie di donne che hanno sfidato pregiudizi e
discriminazioni a più livelli, combattendo contro un sistema storico, politico,
culturale e sociale che le voleva confinare in una posizione subordinata e
sminuente.
Donne che hanno
fatto la storia, come Lucy, che nella loro vita si sono fatte portavoce dell’esigenza
femminile di ribellione ai soprusi di cui da sempre erano state vittime, e
delle istanze rivendicative di condizioni di vita e trattamenti egualitari e
rispettosi delle loro singolarità, qualità e unicità.
