Contenuto della pagina
COSTRUZIONI IDENTITARIE
L'identità di genere
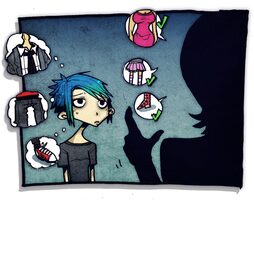
a cura di Veronica Pinto
L'identità di
genere, maschile o femminile, è una costruzione identitaria dai percorsi molto
vari. Si tratta di un processo che ha origine nella primissima infanzia e
prosegue per tutta la vita assumendo stabilità solo nell'epoca
post-adolescenziale. Durante l'adolescenza, infatti, la questione identitaria
assume carattere nucleare, fase di ridefinizione del Sé e dell'immagine di sé
che si rimanda e che si percepisce. In questo periodo della crescita
individuale si realizza una idea sempre più consapevole di se stessi che assume
anche carattere sessuato in senso stretto. Questa fase di passaggio dalla vita
infantile al mondo adulto, di cui si parla solo a partire dalla fine dell'800 e
che, ancora oggi, in molte culture primitive non ha alcun valore normativo,
oggi si costruisce per mezzo di sistemi molto diversi da quelli del passato. I
sistemi e le gerarchie sociali di tipo collettivo facevano da substrato
all'evoluzione dell'individuo entro la comunità, per mezzo di rituali
iniziatici e fasi di celebrazione collettiva volti a sottolineare il passaggio
da uno status sociale ad un altro. Questo passaggio assume, oggi, una
connotazione decisamente più soggettiva ed individuale inserendosi poi in
modalità sociali meno precise e definite. Di conseguenza, essere maschi o
essere femmine oggi, assume un significato di maggiore instabilità sociale
rispetto a quanto avveniva in passato. L'adolescente di oggi deve inserirsi in
percorsi non più rigidamente organizzati (si stanno considerando la maggior
parte delle società occidentali), bensì in aspettative di ruolo meno chiare che
aumentano il livello di complessità e flessibilità. Se questo da un lato crea
dinamismo e presumibilmente maggiore libertà individuale, dall'altro aumenta
l'incertezza soggettiva, soggettività che risulta poco contestualizzata entro
argini rassicuranti. L'ulteriore risvolto della medaglia sarebbe considerare
questi argini come i limiti di una gabbia
imposta dalla società alla personalità del singolo (si approfondisca, a questo
proposito, la teoria Queer[1]).
Parlare di
identità di genere significa realizzare un discorso che concerne le aspettative
relative all'essere maschio o all'essere femmina, entro determinati confini
storico-culturali e psico-sociali. Non si tratta di un concetto meramente biologico[2],
poiché non assimilabile al mero sesso di appartenenza riconosciuto alla nascita
attraverso un atto prima medico, poi giuridico (da un punto di vista
medico-biologico è osservabile fenotipicamente attraverso gli organi
riproduttori esterni e geneticamente attraverso l'analisi del cariotipo, che in
biologia identifica le femmine con cariotipo XX e i maschi con cariotipo XY). L'identità
di genere riguarda strettamente aspettative di ruolo maschili o femminili entro
una determinata cultura, la cui origine, definibile come identità nucleare di genere, si costituisce nella primissima
infanzia, anticipando la consapevolezza della differenza anatomica dei sessi,
già prima dei tre anni di età. Il fenomeno ha strettamente a che fare con il
soggettivo sentirsi maschi o femmine ed è costruito a partire dal fatto che i
genitori pensano al neonato come ad un essere sessuato (si pensi ad esempio, a
quelle pratiche che genitori e parenti mettono in atto ancor prima che il
bambino o la bambina nasca, attraverso l'acquisto di giochi, vestitini o l'allestimento
della stanza con dei colori o delle forme considerate ad hoc per ciascun
genere). Si tratta, inoltre, di un costrutto che ha a che fare con l'immagine
di sé che si costruisce per mezzo del rispecchiamento
nella relazione di base con i genitori. In definitiva si tratta di una
costruzione che ha origine nella primissima infanzia e si fonda su un primitivo
nucleo identitario che presenta sostanziali differenze di base tra maschi e
femmine, differenze culturalmente
connotate. Si potrebbe sintetizzare affermando che l'identità di genere
rappresenta una costellazione di elementi che raccolgono in sé aspetti psicologici,
interessi, valori e attitudini che sono associati in maniera univoca ad un
sesso in base alle aspettative, ai ruoli e alle norme culturali di riferimento
che ruotano attorno a quelle caratteristiche sessuate (Zammuner, 2000).
Le influenze
sociali degli stereotipi culturalmente
definiti (ossia quella serie di ampie categorie che riflettono le impressioni
e le convinzioni che gli individui appartenenti ad una certa cultura,
posseggono su ciò che significhi essere maschi o essere femmine) sono
osservabili nei bambini in tenera età, tra i due e i tre anni. Sono molti gli
studi che hanno evidenziato come i bambini in questa fase siano in grado di
compiere attribuzioni stereotipiche
quando viene loro chiesto quali attività sono più propensi a fare maschi e
femmine. Ad esempio: i maschi sono più adatti a giocare a calcio, a guidare la
macchina, a lavorare fuori casa; le femmine sono più adatte a cucinare, a
cucire, a fare acquisti. La capacità del bambino e della bambina di
riconoscersi come maschi o femmine, dunque, è molto precoce. Già a partire dai
diciotto mesi si assiste ad una primaria discriminazione di aspetti che
interessano l'estetica culturale dell'appartenenza di genere (in particolare
capelli, vestiti e accessori vari). Sono diverse le prove sperimentali che
hanno evidenziato la capacità dei bambini di prendere il disegno giusto quando
viene loro chiesto: "quale di questi bambini sei tu?". E alla stessa età si
osserva anche la capacità di indicare un bambino o una bambina, proprio a
partire da questi connotati estetici, osservando disegni o foto che li
ritraggono. Tutto questo prima ancora che venga acquisita la capacità di
discriminazione genitale (Levorato, 2002). Questo è, ovviamente, associabile
non solo alle funzioni o alle caratteristiche estetiche, ma in particolare alle
caratteristiche cognitive ed emozionali: i maschi sono forti, bravi in
matematica, non piangono mai, sono schematici; le femmine piangono spesso, sono
sensibili, brave in italiano, creative. In sostanza si osserva come bambini di
due anni abbiano già interiorizzato qualche conoscenza sugli stereotipi di
genere e sul ruolo sessuale (Schaffer, 1996). La capacità di associare
caratteristiche di personalità alle femmine e ai maschi è osservabile già a
partire dai cinque anni.
Nel corso dell'infanzia sono
identificabili tre fasi relative all'acquisizione della nozione di genere:
- L'appartenenza
ad un genere è osservabile anche in tempi successivi quando, a partire
dai due anni, i bambini riescono a discriminare il loro essere maschi o
femmine.
- La stabilità
di genere, invece, compare in quel periodo in cui il bambino e la
bambina concretizzano che il sesso di una persona resta invariato per
tutta la vita. Questo si osserva a partire dai quattro anni di età, fase
in cui il bambino e la bambina sono in grado di stabilire se da piccoli
fossero maschi o femmine, oppure, se una volta adulti saranno come la
mamma o come il papà (più genericamente, saranno maschi o femmine).
- La costanza
di genere, poi, consistente nel rendersi conto che il genere rimane lo
stesso a dispetto delle apparenze, si osserva intorno ai 6-7 anni. A
partire da questo periodo i bambini realizzano che una femmina rimane tale
anche se ha tagliato i capelli o che un maschio rimane tale anche se ha i
capelli lunghi, ad esempio. Questa acquisizione completa si verifica
intorno ai 7 anni di età, nel periodo in cui si manifestano quei progressi
cognitivi evidenziati anche dalle prove piagetiane di conservazione della
materia. (Schaffer, 1996)Tra i fattori originanti
l'evoluzione dei ruoli di genere, oltre quelli cognitivi, è possibile indicare
anche i pari, la scuola o i contesti di apprendimento formale, informale e non
formale, la cultura, i media e in particolare la famiglia. Si tratta pur sempre
di una risultante multifattoriale (familiare, biologica, cognitiva, sociale
ecc.). Pur avendo la sua origine nella
primissima infanzia, per proseguire fino alla preadolescenza, è durante
l'adolescenza che lo sviluppo dell'identità di genere, con esso il bisogno di
auto ed etero definizione, diventa preponderante. Già con la preadolescenza e
per tutta l'adolescenza i ragazzi e le ragazze sono chiamati a gestire la serie
di trasformazioni cui sono sottoposti sotto l'influsso ormonale puberale. A
livello cognitivo l'adolescente acquisisce la capacità di rappresentarsi in una
serie molteplice di opzioni possibili, cosa che aumenta il grado di incertezza
e i conflitti sia intrapersonali, sia interpersonali. In questo periodo, il
vissuto del rapporto con il proprio corpo riveste un ruolo centrale rispetto ad
altri compiti evolutivi dello sviluppo e influenza in maniera diretta la
definizione del genere, nonché la propria competenza nel relazionarsi con gli
altri e nel costruire rapporti affettivi significativi. Secondo Gambini è
possibile rilevare una forte correlazione tra la capacità dell'adolescente di
accedere alla sessualità in maniera serena e la capacità di autodefinire il
proprio genere (2007). Il contatto con gli altri, in particolare i coetanei,
determina lo sviluppo dell'orientamento preferenziale verso relazioni più
profonde e la costruzione di relazioni sentimentali svolge una funzione supportiva
per la costruzione del concetto di sé. A tal proposito si può sottolineare
come, proprio per questa particolare correlazione tra l'accesso sereno alla
sessualità e la capacità di autodefinire il proprio genere, gli adolescenti che
si identificano come omosessuali o bisessuali, in alcune particolari
circostanze, anche a partire dai modelli rimandati e rimarcati fortemente dalla
società, possano vivere una fase di confusione identitaria. Solo più tardi, con
il passare del tempo, si accorgeranno di riuscire ad identificarsi chiaramente
nel proprio sesso di appartenenza e che quella breve fase disforica di non
riconoscimento della propria individualità e identità di genere ha a che fare
più con la necessità di aderire ad un modello (coppia maschio-femmina),
piuttosto che ad un non riconoscimento della propria identità generale e
sessuale. Allo stesso modo, gli adolescenti che successivamente si
identificheranno come transessuali, potranno vivere una prima fase in cui
l'attrazione per il proprio sesso biologico li induca ad identificarsi come
omosessuali (lesbiche o gay), individuando solo più tardi la strada più consona
alla definizione personale e alla costruzione dell'identità personale. Nello sviluppo
dell'identità sessuale e dell'identità di genere influiscono numerosi aspetti
di ordine biologico, sociale, culturale, ambientale, emotivo. I cromosomi
sessuali e l'assetto ormonale regolano lo sviluppo di caratteri sessuali primari
e secondari[3]. Lo sviluppo puberale,
nonché lo sviluppo della capacità riproduttiva sono elementi in grado di
influenzare l'identità sessuale, il comportamento, gli atteggiamenti e
l'orientamento sessuale. Si deduce, dunque, quante e in quale misura le più
varie condizioni influenzino lo sviluppo dell'essere umano nelle sue componenti
basilari, tra cui l'identità di genere.
Sono vari i
filoni di ricerca ad essersi interessati al modo in cui i bambini
interiorizzano il concetto di genere. In particolare, la teoria dell'apprendimento evidenzia che la tipizzazione sessuale
si verifica sulla base del rinforzo ricevuto. Sostanzialmente il comportamento
adatto al proprio sesso, socialmente e culturalmente riconosciuto, viene
premiato, enfatizzato, incoraggiato. Al contrario i comportamenti considerati
inidonei sono puniti, sminuiti, ridicolizzati. Sono proprio i padri ad agire in
modo differente nei confronti dei propri figli o delle proprie figlie
contribuendo alla forte differenziazione di genere (Schaffer, 1996): ad esempio
tendono a giocare più facilmente con i figli, rispetto a quanto non facciano
con le figlie, soprattutto se si tratta di giochi come il calcio, la lotta, i
soldatini e simili. In questo, molto spesso, la madre viene riconosciuta
depositaria dei "segreti femminili" e dunque la figura genitoriale preposta a
svolgere giochi come truccarsi, fare la mamma, fare le pulizie. Inoltre, i
padri, sono soliti tollerare maggiormente comportamenti maschili delle figlie
(fino alla preadolescenza) rispetto ad atteggiamenti e comportamenti femminili
dei propri figli (sin dalla tenera età). Inoltre, discutere dei sentimenti è per
i genitori più facile con le figlie che non con i figli. Questo modello si
replica in maniera pressoché identica anche nel gruppo dei pari, che adottano
atteggiamenti e comportamenti differenziati a seconda del sesso con cui si
relazionano e hanno aspettative specifiche a seconda del sesso del soggetto con
cui entrano in relazione (Santrock, 2008).
La teoria dell'apprendimento sociale ritiene l'imitazione un
meccanismo fondamentale nello sviluppo del comportamento di genere. Si
attribuisce un ruolo preponderante al modellamento da parte del mondo adulto:
il bambino, osservando il mondo adulto che lo circonda e i propri coetanei, è
incoraggiato a prestare attenzione selettiva agli individui dello stesso sesso
adottando un modello di comportamento emulativo nei loro confronti. In base a
questa teoria, i bambini non apprendono solo per rinforzo diretto, ma anche per
rinforzo vicario (Bandura, 1977). Questa tipologia di rinforzo si realizza
allorquando i comportamenti osservati e messi in atto da altri sono rinforzati.
L'apprendimento, in questo caso, è di tipo indiretto. La cultura di
appartenenza e i relativi processi di socializzazione svolgono un ruolo
fondamentale nell'orientare la scelta di modelli sociali e culturali
considerati in linea con il genere di appartenenza. Per verificare l'importanza
e l'imponenza delle influenze sociali e culturali nello sviluppo degli
stereotipi di genere, Schaffer (1996) rileva, attraverso un esperimento, come
le persone reagiscano diversamente quando viene loro mostrato un neonato dal
nome e dall'abbigliamento neutro se viene loro detto che si tratta di un
maschietto o una femminuccia:
Nel primo caso reagiranno sottolineando le
caratteristiche considerate tipicamente maschili ("Scommento che è un tipo
tosto"; "Scommetto che è vivace").
Nel secondo caso reagiranno sottolineando le
caratteristiche considerate tipicamente femminili ("Non è carina?";
"Secondo me è molto dolce e affettuosa"). L'approccio cognitivo ha ulteriormente approfondito la questione,
affiancando ai processi del rinforzo e dell'imitazione, anche una serie di
aspetti cognitivi. Il bambino non riceve passivamente le informazioni
dall'esterno, ma le integra e le interpreta in maniera attiva applicandole
selettivamente al comportamento personale e altrui. In questa ottica Kohlberg
(1966) ritiene che l'identità di genere sia l'origine del comportamento che si
associa al genere: le bambine imiterebbero i modelli femminili per una
consapevolezza interna e spontanea di essere femmine e a partire da questa
categorizzazione costruiscono parte della propria identità, così come i bambini
(Levorato, 2002). Sono varie le ricerche che hanno evidenziato come bambini di
tre anni, che risultano rispondere in maniera più corretta sulle prove
dell'identità di genere, mostrino poi una più netta preferenza per i giochi propri
del loro sesso. È tuttavia necessario sottolineare che questo senso di
appartenenza così definito non si evidenzia in tutti i bambini per
caratteristiche proprie, presumibilmente innate. Sin dalla tenera età, nell'età
prescolare, si possono facilmente notare differenze interindividuali tra
bambini e bambine appartenenti a gruppi pressoché omogenei. Alcuni di questi,
infatti, mettono in atto in maniera più automatica dei comportamenti ritenuti
dalla società aderenti al genere di appartenenza. Altri, invece, avranno
comportamenti più sconfinanti, meno definibili: è il caso di quelle bimbe che
vengono criticamente definite dei "maschiacci" e dei bambini che vengono
definiti "docili e sensibili".
Le teorie cognitive dello schema sessuale hanno cercato, invece, di
combinare la teoria dello sviluppo cognitivo accanto a quella
dell'apprendimento sociale. Partendo dal presupposto che uno schema è una vera e propria struttura
cognitiva, ossia una rete di associazioni che guidano la percezione del singolo
individuo (Santrock, 2008), lo schema di
genere si struttura a partire da una serie di modelli da imitare. Esso compare
per la prima volta quando i bambini iniziano ad avere cognizione di cosa sia adeguato
al proprio genere secondo la cultura di riferimento: a partire da questa fase i
bambini si rendono conto che esiste una differenza fra maschi e femmine e
cominciano conseguentemente a classificare anche sé stessi. Al contrario, lo schema sessuale, è una struttura maggiormente
complessa che si compone nel corso dello sviluppo e si caratterizza per una
serie di elementi che si coordinano nel tempo (Martin, Wood, Little, 1990). Costrutti
cognitivi e comportamenti si sviluppano non consecutivamente, bensì
parallelamente; quindi l'osservazione dei comportamenti propri e altrui porta
allo sviluppo di strutture di genere che a loro volta producono una
consapevolezza in grado di indirizzare il comportamento (Schaffer, 1996). In
maniera molto semplicistica si può pensare a quella fase in cui ha inizio
l'autoriconoscimento di essere maschi o femmine: a prescindere dai reali
desideri personali o dalle reali inclinazioni, si avrà la tendenza, per un
periodo più o meno lungo, a mettere in atto comportamenti e ad operare delle
scelte che abbiano strettamente a che fare con il proprio genere. Questo è
tanto più evidente in bambini, pre-adolescenti e adolescenti che pur avvertendo
una dissonanza tra ciò che desiderano e ciò che l'ambiente in cui vivono
richiede, tendono ad accomodarsi alle aspettative di ruolo. Ad esempio: una
bambina a cui piace portare i capelli corti, potrebbe adeguarsi al contesto
facendoli crescere; un bambino a cui piace danzare, potrebbe accondiscendere a
frequentare la scuola calcio per adeguarsi alle aspettative di ruolo.
Lo sviluppo
dell'identità è condizionato fortemente anche dallo sviluppo affettivo e
relazionale. Infatti, lo sviluppo del concetto di sé ha origine dai legami di
attaccamento (Bowlby, 1969) con la formazione di modelli operativi interni, ossia
rappresentazioni mentali delle relazioni intessute con le figure di
attaccamento (genitori o altri significativi). Le rappresentazioni mentali
hanno la funzione di veicolare la percezione e l'interpretazione degli eventi
da parte del soggetto, dandogli la possibilità di prevedere e creare
aspettative su ciò che succederà nella propria vita relazionale. La Ainsworth ha evidenziato
il ruolo dei modelli di attaccamento sul comportamento infantile e sullo
sviluppo del concetto di sé. Tali modelli sono: sicuro, insicuro-ambivalente e
insicuro-evitante. Diversi sono gli studi che hanno sottolineato l'importanza
degli stili di attaccamento nello sviluppo della funzione esplorativa, delle
rappresentazioni mentali relazionali, della scelta del partner e del funzionamento
di coppia, delle rappresentazioni mentali sui comportamenti di accudimento
(Carli, 1995). Pur sottolineando la multifattorialità degli aspetti che
incidono sullo sviluppo del sé e dell'identità di genere, diversi studi
evidenziano l'importanza della qualità delle prime relazioni affettive del
bambino.
Se è vero che
l'identità personale non è un dato, ma una costruzione, quindi un processo che
dura per tutta la vita, è pur vero che questa costruzione assume particolare
rilevanza in certi specifici stadi dello sviluppo personale. In questo processo
costruttivo entrano in gioco non solo le dotazioni naturali, bensì le relazioni
intersoggettive cui l'individuo risulta esposto e di cui si mostra
protagonista. Se la costruzione dell'identità assume, in tal senso, una forte
connotazione sociale e relazionale, è pur vero che necessita di una spinta
pedagogica. La costruzione della propria identità corrisponde in larga misura
al processo formativo dell'individuo e basandosi fortemente su una relazione
tra individui, queste relazioni avranno un carattere ancor più significativo a
seconda del livello di consapevolezza e autonomia delle persone implicate. È
inevitabile un riferimento agli stereotipi
di genere e alla cultura del
pregiudizio che caratterizzano ogni singola società e in molti casi entrano
prepotentemente nel merito di quegli stessi processi di costruzione identitaria
personale. Sostanzialmente, nella costruzione della propria identità e nello
sviluppo di momenti critici di tale costruzione, gli stereotipi di genere e la
cultura del pregiudizio hanno un peso non indifferente. Per molto tempo si è
ritenuto che le categorie sociali, inclusi stereotipi e processi di
stereotipizzazione, fossero l'esito di una attività di primario stampo
cognitivo. Si ritiene, infatti, che le categorie sociali fungano da scorciatoia
mentale nella gestione della realtà che, presentando un elevatissimo numero di
stimoli, potrebbe risultare incomprensibile. In realtà, se da un lato questo è
vero, dall'altro gli stereotipi generalmente associati alle diverse categorie
sociali non vanno a determinare scorciatoie di pensiero, bensì atteggiamenti,
comportamenti e disposizioni reazionarie verso una persona in funzione della
sua effettiva o presunta appartenenza categoriale. Le categorie sociali e gli
stereotipi precedono la formazione del pregiudizio, di cui rappresentano il
versante cognitivo. E' opinione comune considerare i processi che inducono alla
formazione di categorie sociali e relative immagini, ossia gli stereotipi,
siano naturali ed abbiano una funzione neutrale, proprio perché attivate a
livello cognitivo. In realtà, il rischio risiede proprio nell'uso che si fa di
queste categorie sociali e della conseguente formazione di bias
pregiudizievoli. Si può (e il più delle volte succede) incappare in inferenze
scorrette che implicato un certo grado di distorsione cognitiva e che spingono
ad assimilare ad un caso singolo i tratti generali di una specifica categoria.
Il rischio dello stereotipo sta proprio nella forza che esso ha nel determinare
la personale percezione dei casi individuali, costringendo la persona a
deformarli fino ad accordarli con l'immagine generale precedentemente acquisita
in maniera automatica e non pensata. Questa situazione si aggrava nel momento
in cui viene articolato un giudizio di valore sulle immagini o le
caratteristiche riconosciute come distintive di quella categoria, predisponendo
uno spazio all'instaurarsi di un pregiudizio e della messa in atto di
atteggiamenti e comportamenti ad esso fortemente legati. Si innesca, dunque,
una catena causa-effetto di tipo lineare che vede il pregiudizio innestarsi su
un giudizio valoriale, elaborato proprio a partire dai processi cognitivi puri.
Si tratta di una modalità ipersemplificata con cui nella vita quotidiana si
percepiscono persone o cose e che determinano la nostra interazione con esse.
Ritenere che la categorizzazione sociale abbia esclusivamente aspetto
cognitivo, piuttosto che valutativo, ha lo svantaggio di veicolare l'idea che
non esista alcuna dimensione valoriale di fondo nel fatto che le persone
vengano distinte a partire da macro-categorie di base. Ma questa distinzione in
categorie non si ferma, purtroppo, ad un livello superficiale, bensì scende nel
dettaglio determinando giudizi di valore. L'idea comune, che affonda le basi in
una convinzione ingenua, è che sia possibile rappresentare la realtà sociale in
maniera oggettiva e che sia sufficiente sospendere i giudizi di valore in
merito. Questo atteggiamento ingenuo non rende conto del fatto che nella
costruzione di qualsiasi categoria sociale e dell'immagine di essa, esiste
sempre una dimensione soggettiva che ha carattere storico, culturale e sociale.
Qualsiasi insieme di caratteristiche venga attribuita ad una certa categoria
sociale dipenderà dal punto di vista che si è scelto di descrivere. Dunque, il
puro livello di elaborazione cognitiva delle informazione è inesorabilmente
intriso di componenti valutative. Non esiste un modo per elaborare in maniera
neutrale o oggettiva la realtà. Non è possibile categorizzare, così come non è
possibile entrare in relazione con il mondo. L'idea che la costruzione di
categorie e stereotipi non influenzi i processi di costruzione identitaria, non
rende conto dell'alto rischio di manipolazione che parte dal processo di
elaborazione cognitiva per invadere poi, inevitabilmente, anche l'espressione
di giudizi di valore. A tale annoso problema non esiste una soluzione, l'unica
strada praticabile è quella della diffusione di una cultura delle differenze
che diano spazio alle varie forme di espressione del Sé a valore costruttivo e
non distruttivo.
Quanto
detto fino ad ora rende conto della serie di modalità intervenienti nella
costruzione dell'identità di genere e di come la realtà sociale in cui si è
immersi determini necessariamente una serie di processi che da un lato hanno il
merito di semplificare alcune questioni, dall'altro possono operare un danno
enorme complicando fino allo sfinimento la possibilità di autorealizzazione del
singolo. Sostanzialmente se la costruzione dell'identità di genere ha esiti
piuttosto positivi nelle personalità cisgender,
ossia in quelle persone che si riconoscono pienamente (a prescindere dalle
sfumature comportamentali, relazionali e di scelta personale) nel sesso che la
natura gli ha assegnato e che vengono riconosciute dalla società a partire dal
binarismo maschio-femmina, l'altro lato della medaglia è il rischio che la
costruzione identitaria delle persone transessuali
possa incorrere in esiti negativi, non tanto per il grado di sofferenza
individuale, quanto proprio per l'altissimo tasso di stereotipia e pregiudizio
che la società riserva a chi cerca di collocarsi nel mondo trovando la propria
personale stabilità e serenità.
Essere maschi o femmine oggi sta
assumendo caratteristiche nuove e questo cambiamento sociale deve poter offrire
lo spazio per una revisione di quella che è l'idea della mascolinità e della
femminilità. Si tratta di prendere atto che essere donna, eterosessuale,
casalinga e mamma non è l'unica possibilità e che, dall'altro lato, essere
uomo, eterosessuale, lavoratore autonomo o dipendente e padre non è l'unica
possibilità di vivere una vita piena e consapevole. Esistono una serie di forme
alternative, apparentemente nuove, anche se da sempre esistenti, per dare
spazio ad una costruzione identitaria soddisfacente. Dare spazio ad una cultura
delle differenze in tutti i contesti, in particolare in ambito educativo, offre
la possibilità di rivedere il concetto di categoria e i relativi giudizi di
valore. Categorizzare, inteso come dar nome alle cose, non è un problema in sé.
Il problema risiede nel fatto che a partire da queste categorie si possa
incorrere nel rischio di strutturare, cosa che è purtroppo già accaduta nella
storia e tutt'oggi accade, una società basata sul pregiudizio e sulla
discriminazione. Questo tipo di società implica una serie di ricadute sui
processi di costruzione dell'identità di genere e sessuale, coinvolgendo tutti
gli attori sociali e non solo alcune categorie. Si tratta di un problema del singolo
che si realizza a livello socio-culturale e, pertanto, va tenuto strettamente
in considerazione, non soltanto dai professionisti del settore, ma da chiunque
entri in relazione più o meno diretta con bambini, pre-adolescenti ed
adolescenti.
BIBLIOGRAFIA
Addonizio E., Scilligo P.,
"Correlati psicologici del sé relazionale nel transessualismo",
Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 6, 3, pp. 337-386, 2000.
Bandura A., Social learning theory, Englewood Cliffs, Prentice
Hall, New Jersey,
1977.
Bowlby J., Attachment and loss, London: Hogarth Press, 1969 (tr. It. Attaccamento e
perdita, Boringhieri, Torino, 1972).
Carli L., Attaccamento e rapporto
di coppia, Cortina, Milano, 1995.
Comelli D., Scilligo P.,
"Percezione di sé e relazioni familiari nell'omosessualità maschile",
Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 7, 1, pp. 79-114, 2001.
Erikson E.H., Identity and the life cycle,
Northon, Neww York, 1980.
Gambini P., "Sviluppo fisico
e sessuale e costruzione dell'identità di genere in adolescenza: risultati di
una ricerca empirica", Psicologia, Psicoterapia e Salute, vol. 13, 3, pp.
349-369, 2007.
Kohlberg L., "A cognitive-developmental
analysis of children's sex-role concepts and attitudes", In E.E. Maccoby
(Ed.), The development of sex differences, CA, Stanford University Press, Palo Alto, 1996.
Levorato M.C., Lo sviluppo
psicologico. Dal neonato all'adolescente, Einaudi, Torino, 2002.
Martin CL, Wood CH, Little JK., The development
of gender stereotype components, Child Dev. 1990 Dec;61(6):1891-904.
Santrock J.W., Child Development, 2008, (ed. It.
a cura di D. Rollo, Psicologia dello sviluppo, McGraw-Hill, Milano 2008).
Schaffer H.R., Social Development, 1996 (ed. It.
A cura di A.O. Ferraris, Lo sviluppo sociale, Cortina, Milano 1998).
Zammuner V., "Identità di
genere e ruoli sessuali", In S. Bonino (Ed.), Dizionario di psicologia
dello sviluppo, Einaudi, Torino 2000
1] La Teoria Queer è una teoria
critica sul sesso e sul genere che ha avuto origine negli anni '90 in seno alla
vasta letteratura sugli studi di genere e supportata dalle teorie femministe.
Tale teoria si pone l'obiettivo di mettere in discussione la naturalità
dell'identità di genere e dell'identità sessuale, affermando che esse sono
interamente o in parte costruite dalla società. L'individuo, quindi, non può
essere descritto realisticamente con il mero utilizzo di macrocategorie
generali e antitetiche quali "uomo/donna", "eterosessuale/omosessuale" ecc.
[2] Oltre
l'aspetto genetico riconosciuto (cariotipo maschile o femminile e tutte le
possibili intersezioni), negli ultimi vent'anni la scienza si è adoperata al
fine di individuare uno o più geni che rendano conto dell'ipotesi di una
sessualità cerebrale, generata sin dallo sviluppo fetale e che si realizza e viene
rimarcata nel corso della esistenza dell'individuo. Queste ricerche sono state
condotto a partire da due campioni: soggetti con evidente intersessualità e
soggetti transessuali.
[3] In biologia i caratteri sessuali sono le
caratteristiche anatomiche che consentono di identificare un individuo come
maschio o femmina, ossia i due sessi rintracciabili nelle specie a riproduzione
sessuata. L'anatomia consente di distinguere fra caratteri primari e secondari.
I primi sono quelli relativi alla presenza dell'apparato genitale di genere
(ovaie, utero e sesso femminile; testicoli e sesso maschile). I secondi,
invece, caratteri che compaiono successivamente, nel corso dello sviluppo, in
quella fase della vita umana identificata con il nome di pubertà, a forte
carica ormonale, e che si realizza nel corso dell'adolescenza. I caratteri secondari
maschili sono per esempio: la crescita dei peli e della barba,
l'allargamento delle spalle e il rafforzarsi dei muscoli, l'ingrandimento
del pene, dei testicoli e della prostata.
I caratteri secondari
femminili sono per esempio: la crescita dei peli del pube, la crescita del
seno, l'allargamento del bacino, l'inizio delle mestruazioni.
