Contenuto della pagina
Cure me, I'm gay
Il controverso rapporto tra omosessualità e salute mentale
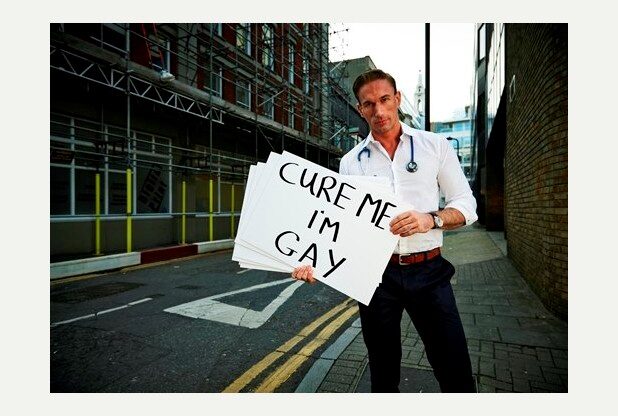
A cura di Daniela Scafaro
Cure me, I'm
gay - Mi curi, sono gay è il titolo di un "docureality" in cui mi sono
casualmente imbattuta girovagando per il web e di cui ho potuto guardare solo
una sorta di piccolo "trailer" (https://www.youtube.com/watch?v=s8aMdexrPW0) dal momento che il format, trasmesso dalla rete britannica
Channel 4, non è ancora giunto in Italia (e chissà se mai vi giungerà).
Nonostante il titolo possa sembrare ambiguo, a quanto
ho capito, è più che altro volutamente provocatorio. Il programma, affidato
al Dott. Christian Jessen, noto ai più come volto di alcuni programmi in
onda su Real Time, si propone di esplorare il mondo delle cosiddette "terapie riparative".
Oltre ad intervistare coloro che si sono sottoposti a
queste famigerate "cure" (alcuni persino ritenendole efficaci), nel suo viaggio
tra USA e Regno Unito, il Dott. Jessen, dichiaratamente omosessuale, ha anche
scelto di sottoporsi in prima persona ad
alcune di queste barbare pratiche.
Nel breve frammento di video che pubblicizza il
documentario, s'intravede come - in una sorta di inquietante "ispirazione
kubrickiana"- dopo aver bevuto un sostanza in grado di indurre nausea e vomito,
all'uomo vengano presentate alcune immagini di uomini nudi...
Purtroppo simili atrocità non rappresentano certo una
novità. Gli omosessuali hanno sempre dovuto fare i conti con persecuzioni e
violenze che raramente hanno visto tregua esprimendosi in modi diversi a
seconda del momento storico; questa lunga storia di crudeltà ha lasciato tracce
indelebili nella coscienza di gay e lesbiche al punto che essi stessi sono
arrivati a considerare la violenza di cui ancora oggi sono vittime come
qualcosa di normale e in un certo senso inevitabile (Borrillo, 2009; Lingiardi
& Vassallo, 2011).
Tutto questo unitamente all'atteggiamento
socio-culturale eterosessista ha fortemente influenzato le convinzioni di
medici e psicologi innescando un vero e proprio circolo vizioso per cui da una
parte la ricerca scientifica rispecchiava il pregiudizio dilagante e,
dall'altra, la comune intolleranza diffusa a tutti i livelli sociali trovava
conforto e una valida legittimazione nelle teorie scientifiche (?), oltre che
nella condanna religiosa, morale e penale di cui gli omosessuali sono stati vittime
per secoli (Montano, 2000).
Fino alla fine del XIX sec. l'omosessualità era
ancora considerata una patologia psichiatrica e il paradigma prevalente era
quello dell'inversione (dei tratti di genere), cui si cercava di porre rimedio
con trattamenti d'inaudita crudeltà (ricondizionamento masturbatorio,
clitoridectomia, terapia ormonale, somministrazione di LSD, elettroshock,
ipnosi, terapia avversiva, lobotomia) che miravano all'a-sessualizzazione o
alla riconversione all'eterosessualità (Katz, 1976).
Alla base di simili atrocità c'era la convinzione che
lo sviluppo psicosessuale fosse un processo rigidamente articolato in tappe
che, se adeguatamente superate, avrebbero condotto il soggetto
all'eterosessualità intesa come approdo normativo e garanzia di maturità e
salute mentale. L'univocità e rigidità di questo modello di sviluppo hanno
fatto sì che il discorso sull'eziologia andasse a coincidere con quello sulla
patologia: non solo l'eventualità di un orientamento omosessuale "normale" non
veniva affatto contemplata ma, soprattutto, si riteneva che l'omosessualità
fosse determinata da cause patologiche di cui, di conseguenza, si andò alla
ricerca (rapporto troppo intimo con la madre, assenza del padre, esperienze
traumatiche...).
Solo negli
ultimi trent'anni sono stati fatti dei passi avanti e ci sono state innovazioni
di rilievo che hanno portato a riconoscere come arbitraria qualsiasi
classificazione o gerarchizzazione degli orientamenti sessuali. Se infatti può
sembrare legittimo interrogarsi sui propri desideri o cercare di conoscere le
ragioni che condizionano le proprie preferenze sessuali, la problematizzazione
di un tipo di desiderio a scapito di tutti gli altri costituisce di per sé una
forma di omofobia in quanto si fonda sul pregiudizio che esista una sessualità
normale, compiuta e completa (l'eterosessualità) e che solo le persone che vi
si conformano possano essere considerate "normali" (Dorais, 1994).
Sarà però solo
tra gli anni '70 e '80 che si assisterà ad un radicale cambiamento grazie al
contributo del nascente associazionismo (movimenti di liberazione omosessuale)
nella lotta all'emancipazione dell'universo LGBT (acronimo che diverrà comune a
partire dagli anni '90) e ad alcuni studi empirici di tipo comparativo (Kinsey et
al., 1948; Kinsey et al., 1953)
che hanno smentito l'ipotesi di una correlazione tra orientamento omosessuale e
disturbi mentali mettendo inoltre in evidenza l'estrema variabilità del
comportamento sessuale.
L'evento che
sicuramente ha costituito uno spartiacque, segnando un punto di svolta nella
progressiva nascita di una nuova consapevolezza in merito al tema
dell'omosessualità, è stata la pubblicazione nel 1972 del libro "Society and
the healthy homosexual" dello psicologo americano Weinberg, in cui per la prima volta compare il concetto
di "omofobia" che si rivelerà rivoluzionario e che permetterà di ribaltare la
questione spostando il "problema" dall'omosessualità all'atteggiamento
stigmatizzante degli eterosessuali nei confronti di gay e lesbiche (e alle sue
conseguenze) inaugurando un nuovo filone di studi.
Nel 1973 l'American
Psychiatric Association (APA) rimuove l'omosessualità egosintonica dalla
lista delle malattie mentali del Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM). Nel 1987
viene abolita anche la diagnosi di omosessualità "egodistonica" evidenziando
così il legame tra la non accettazione del proprio orientamento sessuale e
l'interiorizzazione dell'ostilità sociale (omofobia interiorizzata). Nel 1993
la stessa decisione sarà ufficialmente condivisa dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Più recentemente, infine, ulteriori passi in avanti sono stati mossi grazie
al filone dei Sex & Gender Studies che radicano il nuovo
paradigma interpretativo dell'omosessualità nell'ambito della riflessione sul
concetto di genere come costruzione sociale che si origina nell'evoluzione
della cultura umana e non nella biologia (Lorber, 1994).
Nel
2000 l'APA emette un documento, Position
Statement on Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation - Reparative or Conversion Therapies, in
cui:
disconosce qualunque trattamento psichiatrico basato
sull'assunto che l'omosessualità possa essere un disturbo mentale e mirato
a indurre il soggetto a modificare il proprio orientamento sessuale;
sottolinea l'assenza di dati scientifici rigorosi a
sostegno delle terapie riparative;
mette in
guardia dai danni procurati dalle stesse.
Sempre nel 2000 e con più decisione nel 2005, l'APA
si esprime inoltre a favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
specificando che non si tratta di una presa di posizione "politico-legale" ma
di un intervento per la tutela della salute psichica delle persone omosessuali
che devono poter beneficiare, come tutti i cittadini, dei vantaggi affettivi e
cognitivi derivati dalla sicurezza e dal riconoscimento sociale delle loro
relazioni.
Si è arrivati quindi all'idea che non esiste un
orientamento sessuale subalterno e uno normativo, uno naturale e l'altro
innaturale ma percorsi diversificati e orientamenti alternativi dotati di pari
legittimità. Le persone omosessuali condividono la medesima eventualità di
quelle eterosessuali d'incorrere, nell'arco della propria esistenza, in una
qualche patologia mentale: la fonte dei problemi che spesso affliggono gay e
lesbiche è infatti per lo più da ricondurre all'interazione con un ambiente
sociale stigmatizzante e discriminatorio.
Oggi, alla luce di questa nuova consapevolezza,
escludendo l'isolata attività di qualche folle (si veda Joseph Nicolosi e il
NARTH - Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità),
la psicoterapia con gay e lesbiche si pone quindi l'obiettivo di aiutare le
persone a riconoscere e rispettare le direzioni del proprio desiderio e a
comporre il senso assolutamente personale della propria identità tra genere,
orientamento sessuale e cultura sociale (Lingiardi, 2007) in modo da facilitare
l'acquisizione di strumenti per fronteggiare al meglio l'omofobia, sia quella
interiorizzata che quella presente nella società (Rigliano e Graglia, 2006;
Rigliano, Ciliberto, Ferrari, 2012).
Riferimenti
·
Borrillo D.,
Omofobia. Storia e critica di un
pregiudizio, Edizioni Dedalo,
Libelli
vecchi e nuovi, Nr. 13,
Bari, 2009.
·
Dorais M. (1999), Eloge de la diversité sexuelle, VLB, Montreal.
·
Katz
J. (1976): Gay american history, .Crowell,
New York
·
Kinsey
A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E. (1948), Sexual
Behavior in the Human Male, Sanders, Philadelphia, trad.
comportamento sessuale dell'uomo, Bompiani, Milano (1950). It. Il
·
Kinsey
A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E., Gebhard P.H. (1953), Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia, Sanders.
·
Lingiardi V., Citizen Gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale, il
Saggiatore, Milano, 2007.
·
Lingiardi V., Vassallo N., Classificazioni Sospette, In Nussbaum M.C., Disgusto e Umanità.
L'orientamento sessuale di fronte alla legge, Il Saggiatore, Milano, 2011.
·
Lorber J. (1994), L'invenzione dei sessi,
Il Saggiatore, Milano.
·
Montano A. (2000), Psicoterapia con clienti
omosessuali, McGraw-Hill, Milano.
·
Rigliano P., Graglia M. (a cura di), Gay e lesbiche in psicoterapia,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
·
Rigliano P., Ciliberto J., Ferrari F., Curare i gay? Oltre l'ideologia ripartiva
dell'omosessualità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012.

- FINALMENTE L'OMOSESSUALITÀ VIENE RICONOSCIUTA COME VARIANTE NON PATOLOGICA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE
