Contenuto della pagina
Fatti non foste per viver come...bulli! Quando l'omofobia circola nei gruppi dei pari.
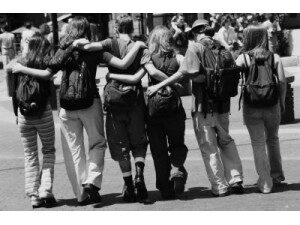
A cura di Carmen Ricci
È cosa ormai risaputa che il
gruppo dei pari ricopre un ruolo molto importante nello sviluppo dell'identità
in adolescenza. Esso, infatti, sostiene il ragazzo nel processo di
emancipazione dai genitori e, in generale, dagli adulti fornendogli un sistema
di valori a cui far riferimento proprio quando quelli infantili vengono
abbandonati. L'aggregarsi con i coetanei non solo permette all'adolescente di
sperimentarsi al di fuori della sua cerchia familiare, ma anche di assimilare
una serie di credenze, atteggiamenti e
comportamenti tipici del proprio gruppo di appartenenza. Nel gruppo
l'adolescente sembra trovare un ambiente congeniale e rassicurante, che
favorisce il distacco dalla famiglia e la conquista dell'autonomia personale;
dunque, è possibile configurare l'esperienza con i coetanei come una sorta di
preparazione alla vita adulta (Ausubel, 1977) e il gruppo dei pari come uno
spazio intermedio, tra mondo infantile e quello adulto, in cui il soggetto
esprime se stesso attraverso l'azione.
Nel gruppo dei coetanei l'azione del
soggetto singolo stimola lo scambio e le reazioni degli altri componenti in un
processo di interazione; in tal senso, l'azione possiede una dimensione
esperienziale (Amerio, 1987). All'interno di questo "spazio protetto",
l'adolescente ha la possibilità di sperimentarsi in quanto persona singola,
attraverso movimenti di differenziazione ed espressione di Sé dall'altro, e in
quanto membro di un gruppo, attraverso comportamenti rispecchianti fenomeni di
conformismo ed omogeneità. Quanto esposto fin ora descrive brevemente gli effetti
benefici ed evolutivi dell'essere parte di un gruppo. Ma non è sempre così! A
volte far parte di un gruppo può alimentare e sostenere azioni aggressive e violente,
poiché portatore di una cultura aggressiva. Molti studi hanno indagato i
fattori che conducono un gruppo di coetanei a strutturarsi attorno ad un'azione
di tipo violenta e deviante. Alcune indagini hanno evidenziato come aspetti
strutturali, come la compattezza, possano amplificare i comportamenti dei
membri del gruppo (Emler & Reicher, 2000); altre evidenziano come, nei
gruppi violenti è proprio la violenza lo strumento attraverso cui si creerebbe quel
"Noi" che solitamente si origina dalla socializzazione di gruppo (Baraldi,
1994). In entrambi i casi, sembra emergere un potere proprio della gruppalità
capace di sostenere ed alimentare credenze, atteggiamenti e comportamenti prevaricanti
verso chi è esterno al gruppo.
Trasportando tali considerazioni alle situazioni
in cui viene agita l'omofobia, sembra importante chiedersi quali sono i
meccanismi sottostanti per comprendere meglio cosa accade.
...e allora, cosa può succedere
quando il gruppo è portatore di un cultura omofobica?
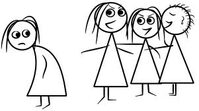
La letteratura scientifica,
interessata alle prevaricazione di stampo omofobico, si è molto focalizzata sul
ruolo assunto dal gruppo nelle dinamiche omofobiche, poiché una delle
caratteristiche peculiari delle prevaricazioni di matrice omofobica è da
rintracciarsi nella gruppalità dell'azione. È stato dimostrato non solo l'alta
probabilità che siano gruppi di ragazzi/e ad agire prepotenze omofobiche nei
confronti di un loro pari (Rivers, Duncan & Besag, 2007) che è o sembra
essere omosessuale; ma anche che il clima di gruppo influenza tantissimo i
comportamenti degli individui, membri di quel gruppo. In particolare, tanto più
il clima del gruppo dei pari è caratterizzato da aggressività ed omofobia,
tanto più i membri del gruppo tenderanno a mettere in atto aggressioni omofobiche
(Poteot, 2008). Non solo, ma è possibile che la socializzazione di gruppo muova
gli individui verso l'adesione a stereotipi e pregiudizi omofobici: gli
studenti che frequentano gruppi connotati da alta omofobia tendono ad aderire a
questo tipo di atteggiamento esattamente come gli studenti che frequentano
gruppi connotati da bassa omofobia tendono a diminuire i loro livelli di ostilità o aggressione
verso le persone omosessuali (Poteot, 2007). È questo il tipico esempio in cui
la cultura di gruppo dà forma al pensiero individuale. Anche il desiderio di
accettazione all'interno del gruppo dei pari spinge i singoli a fare proprio
l'approccio altrui, sia esso di accettazione o rifiuto verso chi o sembra
essere omosessuale.
Le prevaricazioni omofobiche
sembrano riprodurre una parte dei meccanismi presenti anche nei gruppi devianti.
In primis, un ruolo importante è ricoperto dal contagio sociale, ossia
il fenomeno per cui i comportamenti umani, sia in collettività ristrette che
ampie, sembrano tendere verso una sorta di omogeneità; e lo stesso vale per le
emozioni che tendono a trasmettersi nelle interazioni dei gruppi.
Secondo Le
Bon (1895) nelle situazioni di folla individui normali si trasformano in
soggetti violenti e irrazionali, in quanto si svilupperebbe una mentalità
collettiva alimentata da 3 elementi fondamentali:
. il senso di anonimato e di
impunità;
. la rapidità della trasmissione
delle informazioni;
. la tendenza alla
suggestionabilità e manovrabilità degli individui.
Anonimato, contagio e
suggestionabilità causerebbero negli individui perdita di razionalità e di
identità, creando la mente di gruppo sotto il cui influsso si scatenerebbero
gli istinti distruttivi degli individui generando violenza e comportamenti
irrazionali. Nel caso dell'aggressione omofobica in gruppo, il meccanismo del contagio
sociale sembra essere sostenuto non solo dai membri di quel gruppo specifico,
ma anche da un contesto sociale allargato che, spesso implicitamente, incoraggia
e trasmette una cultura eteronormativa e discriminante nei confronti dell'omosessualità.
Ma discriminare la persona omosessuale, o presunta tale, significa non solo rinforzare
una cultura secondo cui l'eterosessualità è da considerarsi la norma, ma anche l'identità
eterosessuale di ogni membro del gruppo (Askew & Ross, 1988). Al contagio
sociale sembrano essere connesse tutte quelle "tecniche" e strategie di disimpegno
morale tese a disperdere la responsabilità dell'azione e distribuirla a
tutto il gruppo, così da attenuare, ridurre la responsabilità individuale. Con
la diffusione della responsabilità le persone in gruppo tenderebbero a sentirsi
meno responsabili per comportamenti legati alle violazioni delle regole. Altre
forme di disimpegno morale sono, invece, legate alla persona che subisce la
prepotenza. Con la deumanizzazione, infatti, si tende a privare la vittima delle
caratteristiche umane, mentre con la sua
colpevolizzazione, si attribuisce la colpa alla persona vittima di una violenza.
Conseguenza possibile della colpevolizzazione è il riconoscimento della qualità
violenta dell'azione compiuta. Il fenomeno del "victim blaming", ossia la colpevolizzazione della vittima, può
prendere varie forme nel caso dell'aggressione omofobica e rende molto più difficile
chiedere un sostegno. Questo perché chiedere aiuto, in questo caso, significa
centrare l'attenzione sulla propria omosessualità - vera o ipotizzata - con i
relativi vissuti di ansia, vergogna e disistima (Prati & Pietrantoni, 2010).
Questa breve esposizione di
alcuni meccanismi sottostanti alle violenze di matrice omofobica mostra la doppia
natura della gruppalità: da una parte un gruppo che si configura come risorsa
evolutiva necessaria per lo sviluppo e il benessere individuale; dall'altro un
gruppo che presenta elementi di rischio da tenere a mente affinché quelle che
sono solo pericoli in potenza non si trasformino in azione concreta.
Riferimenti Bibliografici
o
Askew, S. & Ross, C. (1988). Boys Don't Cry: Boys and Sexism in Education. Milton Keynes, UK: Open University
Press.
o Amerio,
P. (1987). Individui e gruppi nell'ottica cognitiva psicosociale. In Trentini,
G. (a cura di), II cerchio magico. Milano, F. Angeli, 1987, pp. 21-54.
o
Ausubel,
D.P. (1954). Theory and Problems of Adolescent Development. New York,
Grune and Stratton (revisione
nel 1977 con Montemayor, R. e Svajian, P.).
o Baraldi,
C. (1994). Suoni nel silenzio. Adolescenze difficili e intervento sociale.
Franco Angeli, Milano.
o Elmer,
N. & Reicher, S. (2000). Adolescenti e devianza. Il Mulino,
Bologna.
o Fonzi,
A. & Menesini, E. (1988). Conformismo e autonomia: la funzione del
gruppo dei pari nell'adolescenza. Rivista di Psicologia Psicoanalitica,
37, pp.61-77.
o Le
Bon, G. (1895). Psicologia delle folle.
o
Poteot,
V. P. (2007). Peer group socialization of homophobic attitudes and behavior during
adolescence. Child Development, 78 (6), 1830-1842.
o
Poteot,
V. P. (2008). Contextual and moderating effects of the peer group climate on use of
homophobic epithets. School Psychology Review, 37, 188-201.
o Prati,
G. & Pietrantoni, L. (2010). Bullismo Omofobico: prospettive teoriche e
dinamiche psicosociali. In Prati, G., Pietrantoni, L., Buccoliero, E.
& Maggi, M. (2010). Il Bullsimo Omofobico. Manuale teorico-pratico per
insegnanti ed operatori. Franco Angeli, Milano.
o
Rivers,
I., Duncan, N. & Besag, V. E. (2007).
Bullying:
A Handbook for Educators and Parents. Westport, Preger Publishers.
